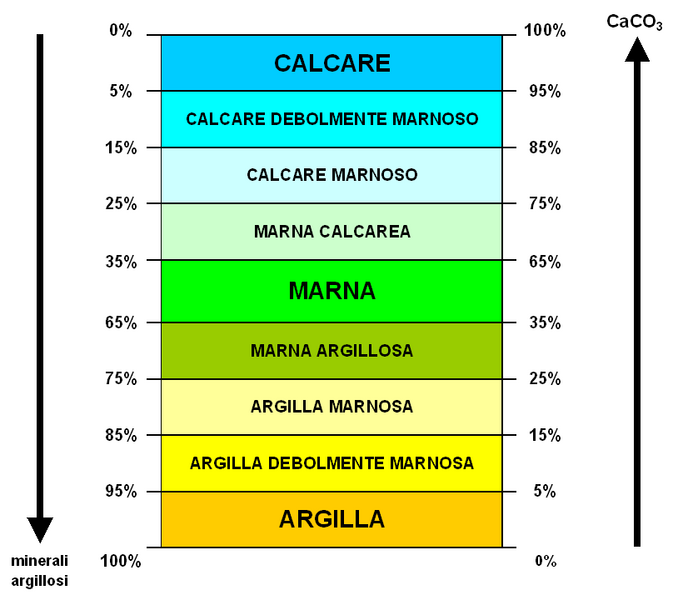Avevo promesso di parlare della tesi di laurea sull'uso del preparato 501 a La Distesa e così ho pensato di chiederne una sintesi direttamente all'autore, Giulio Masato. Giulio dopo la laurea triennale in enologia ha pensato bene di proseguire gli studi con la magistrale in agraria e dunque oggi è un giovane tecnico dalla formazione completa pronto per confrontarsi con il mondo della produzione (in questo momento sta lavorando nella zona di Bordeaux).
Nessuna quantità di esperimenti potrà dimostrare che ho ragione; un unico esperimento potrà dimostrare che ho sbagliato. Ho concluso così la presentazione della mia tesi di laurea, perché questa frase, scritta da Einstein, mi riportava nella direzione di quello che sentivo come il vero significato di questo lavoro. Dall'inizio, e durante i mesi in cui ho lavorato alla mia tesi di laurea, mi sono chiesto spesso se fosse davvero importante dimostrare qualcosa con la mia tesi. Se lo scopo fosse veramente quello di provare scientificamente che la biodinamica funziona. Alla fine mi sono reso conto di essere lontano da tutto ciò, e che questa prova nasceva da una semplice curiosità. Dall'attrazione verso qualcosa, da un'intuizione, dall'osservazione di un fenomeno che non si è ancora in grado di spiegare, dal voler provare ad entrare un po' più nello specifico dei meccanismi che regola.
La tesi ha riguardato la valutazione degli effetti del preparato cornosilice in seguito alla sua applicazione in vigneto. Abbiamo deciso di effettuare quattro trattamenti nel corso della stagione vegetativa, a partire dalla prefioritura, fino a ridosso della maturazione. Le applicazioni sono state effettuate consultando il calendario lunare di Maria Thun, e seguendo parallelamente altre sperimentazioni portate avanti grazie ad una collaborazione tra il professor Mario Malagoli ed Adriano Zago, agronomo ed enologo consulente in ambito di agricoltura biodinamica.
Conoscendo Corrado ed il suo modo di lavorare, le sue vigne ci sembravano il luogo adatto in cui impostare lo studio. Innanzitutto per il suo interesse a portare avanti prove sperimentali all'interno de La Distesa, ma anche perché fino ad allora non aveva mai impiegato il 501. Ciò appariva interessante nell'ottica di valutare gli effetti del preparato in un ambiente già equilibrato, ma estraneo al suo utilizzo.
In relazione agli effetti imputati al cornosilice ed all'elemento Silicio, da Steiner, e partendo dalla consultazione di altri studi riguardanti il ruolo del Silicio stesso nella fisiologia vegetale, abbiamo dunque ipotizzato che l'applicazione del preparato cornosilice in vigneto potesse avere degli effetti a livello morfologico e fisiologico nella pianta. In particolare abbiamo considerato che durante la crescita vegetativa quest'ultimo potesse avere un effetto sull'accrescimento e sul "portamento" della vegetazione, e sulla capacità fotosintetizzante delle foglie. In fase di maturazione si è invece ipotizzato che il 501 potesse mostrare degli effetti su cinetica di maturazione e qualità del frutto, ed infine che potesse stimolare l'autoregolazione dei meccanismi di difesa della pianta stessa.
Lo schema sperimentale è stato impostato in due parcelle di Verdicchio adiacenti. Queste risultavano infatti confrontabili per quanto riguarda varietà, esposizione, condizioni pedoclimatiche e gestione colturale, invece si distinguevano per età dell'impianto, clone, portinnesto, densità e sesto d'impianto. All'interno di entrambe le parcelle sono state dunque assegnate, a coppie di filari, le tesi Trattato e Testimone in modo randomizzato, alternando ad esse dei filari tampone per cercare di escludere un possibile effetto di deriva del preparato nebulizzato.
Durante la fase di massima crescita vegetativa abbiamo quindi effettuato delle analisi morfometriche direttamente in vigneto, al fine di valutare un eventuale effetto del cornosilice sullo sviluppo e sul portamento della vegetazione stessa. In corrispondenza di queste misurazioni abbiamo inoltre raccolto campioni fogliari che abbiamo successivamente analizzato in laboratorio per valutarne la concentrazione di clorofille, di Carbonio, Azoto e Zolfo, oltre ad altri microelementi.
In seguito, dall'invaiatura alla raccolta, abbiamo raccolto campioni di acini, per sottoporre anch'essi ad analisi di laboratorio, e valutare eventuali effetti del preparato biodinamico sulla qualità dell'uva e sulla cinetica di maturazione. Nello specifico abbiamo valutato il peso degli acini ed il peso delle bucce, la concentrazione di solidi solubili, l'acidità totale, la concentrazione di polifenoli presenti nelle bucce ed è inoltre stata effettuata un'analisi all'HPLC per analizzare il contenuto in glucosio, fruttosio, acido tartarico ed acido malico.
I risultati ottenuti da questa tesi hanno evidenziato che l'applicazione del preparato biodinamico 501 in vigneto mostra degli effetti positivi sulla fisiologia della pianta in fase di accrescimento vegetativo e sulla maturazione del grappolo. A livello fogliare si è infatti osservato un aumento statisticamente significativo delle concentrazioni di pigmenti (clorofille e carotenoidi) e di azoto. Tali dati sembrerebbero avvalorare l'ipotesi di un effetto del preparato 501 sull'efficienza fotosintetica, e sullo stato nutrizionale della pianta. I due aspetti potrebbero inoltre risultare correlati considerando l'importanza dell'azoto nella composizione delle molecole di clorofilla.

A livello del grappolo invece è emersa un'influenza su alcuni aspetti collegati alla fase di maturazione. Tra questi si è riscontrato in modo più evidente un incremento nell'accumulo di zuccheri ed un ispessimento delle bucce. Tali effetti del 501 sono però risultati statisticamente significativi solo all'interno del vigneto più maturo in termini di età.
Per quanto riguarda gli zuccheri, se ne è osservata una concentrazione significativamente maggiore nel Trattato rispetto al Controllo in corrispondenza della prima data di campionamento degli acini. Nelle date successive invece, per quanto rimanesse questa differenza a favore delle piante Trattate, questa non risultava tale da essere statisticamente significativa. Sulla base di ciò abbiamo ipotizzato un possibile effetto del 501 nel far avanzare la maturazione del grappolo, in termini di accumulo di zuccheri.
In relazione invece alla differenza significativa di peso tra le bucce di piante Trattate e quelle di piante di Controllo, l'effetto osservato potrebbe avvalorare la tesi secondo la quale il preparato 501 è in grado di stimolare i meccanismi interni di difesa della pianta. Tra questi, la pianta sembra infatti mettere in atto un ispessimento delle bucce come primo meccanismo di autodifesa da patogeni esterni.
Questi sono solo piccoli dati raccolti, che se vogliamo hanno anche poco a che fare con la biodinamica in sé. Per alcuni aspetti ritengo siano molto interessanti, ma penso anche necessitino di essere estesi, verificati in altri ambienti e condizioni diverse, e quindi arricchiti da altre sperimentazioni.
Li ritengo però un contributo importante a chi cerca all'interno delle università di scollare dalla poltrona vecchi dogmi che abbiamo l'urgenza di superare. Per ritrovare dei concetti, come l'umiltà, la curiosità e l'etica, un po' persi nell'applicazione del modello scientifico. E forse, liberandosi da evidenti ipocrisie e quindi da interessi personali, si potrebbe iniziare proprio nelle università ad assumersi la responsabilità di ridiscutere con forza l'attuale modello agricolo, o meglio agroindustriale.
Quando cambiamo il modo di coltivare il nostro cibo, cambiamo il nostro cibo, cambiamo la società, cambiamo i nostri valori
Giulio Masato